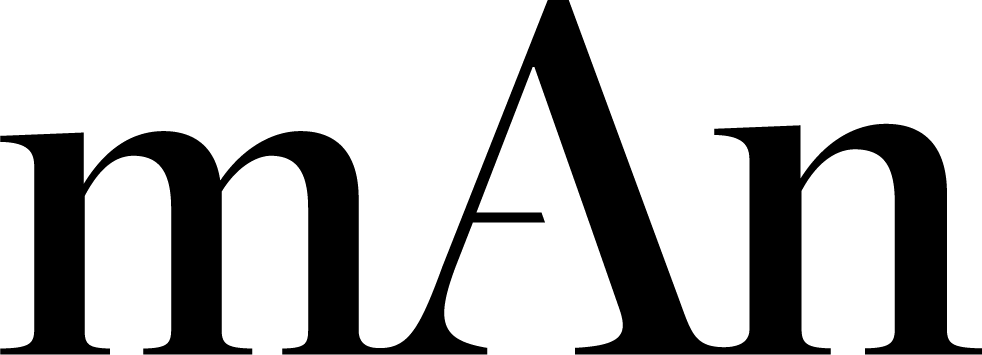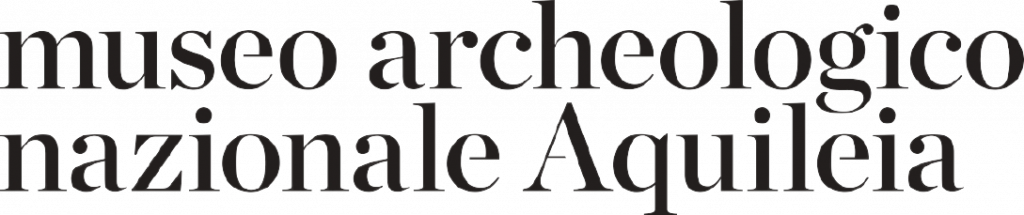La loro costruzione venne decisa nel 1898, in concomitanza del Giubileo di regno di Francesco Giuseppe, al fine di ricoverare i monumenti lapidei, fino a quel momento in parte sistemati in Museo, in parte sparsi nel giardino. Il primo braccio venne eretto entro il 1908, su un progetto unitario del prof. G. Neumann. Allo stesso tempo si provvide al rimboschimento del giardino. Di questa fase si possiedono numerose foto d’epoca. Per l’innalzamento del secondo braccio si giunge al 1939, mentre il quadriportico alla spalle del lapidario vecchio ed altre due gallerie vennero costruiti negli anni Cinquanta. Nel Lapidario così costituitosi trovano coerente sistemazione ingenti materiali, divisi per tipologia e ordinati in ordine cronologico nei singoli bracci: le classi più significative sono certamente date dai monumenti funerari e dai mosaici. Le attestazioni funerarie sono state disciplinate in modo da offrire una visione organica dei diversi modelli presenti ad Aquileia, ciascuno dei quali fornisce informazioni su consuetudini sociali e famigliari e su credenze religiose e spirituali. Assai suggestivo è il braccio in cui sono raccolte le are. Tale tipo di monumento, a forma di parallelepipedo, si articola come una struttura architettonica su zoccolo a gradini e con alto coronamento a cuspide: preferito da liberti e soldati, va collocato nel I sec.d.C.
Altrettanto interessante è la visione dei bracci con le stele: un loro esame permette di cogliere l’esistenza di numerose particolarità nella struttura e nella decorazione. Va notato il gruppo unitario relativo a fanti e cavalieri delle legioni XI Claudia e I Italica, stanziati in città per la difesa dei confini orientali, databili tra la fine del III e la prima metà del IV sec.d.C. Esse restituiscono l’onomastica dei soldati, dei quali si nota l’origine barbara, l’abbigliamento e i tipi di armi a ricomporre un quadro unitario. Non vi sono cenni, nelle più tarde, che alludano a credenze cristiane, a confronto di altri monumenti coevi di militi nel Museo Paleocristiano.
Nel giardino, infine, è stato ricostruito il monumento funerario dei Curii, databile entro la prima metà del I sec.d.C. Consta di un basamento sul quale si imposta un’edicola con copertura piramidale: all’interno è stata collocata una statua non pertinente, al fine di restituire l’aspetto originario, che è quello in cui potrebbe essere ambientato il Navarca. E’ stata ricomposta la fronte del recinto, con cippi angolari: la lunga iscrizione ricorda quattro generazioni della famiglia, di origine libertina. Passando ai mosaici, nell’ultimo braccio del Lapidario sono esposti i mosaici provenienti dal vasto complesso delle Grandi terme, posto nella parte occidentale della città, fra Circo e Anfiteatro. Le indagini si sono concentrate su di un grande salone, il cui pavimento ha mostrato una partitura ricca ed articolata, basata su un quadrato centrale con il trionfo di Nettuno. Attorno erano disposti sedici pannelli, variamente campiti. Sui lati nord e sud il salone presentava ancora due pannelli rettangolari con busti di atleti entro ottagoni e quadrati. La grande sala faceva parte, quale ambiente di disimpegno, del frigidarium, ossia del settore dove si prendevano i bagni in acqua fredda: il complesso va datato nella seconda metà del IV sec.d.C.